Fonte: www.dellamoda.it
Tratto dal libro:
Un boccone dopo l’altro
di Roberto Ostuzzi e Gian Luigi Luxardi
Baldini Castoldi Dalai Editore, 2007
«Peso alla nascita: 3.900 gr» Posso tranquillamente dire che è stata l’unica volta in vita mia in cui ho avuto un peso «normale». Sono nata il 10 ottobre alle otto di sera, una Bilancina ascendente Leone. Sono la primogenita. I miei erano sicuri che mi aspettasse un luminoso futuro. Ero una bellissima femminuccia, anche le foto lo confermano, ero ben proporzionata. Assomigliavo a mio padre, ma in versione bella, stando a quanto dicevano parenti e amici.
Mia madre non aveva latte e questo l’aveva gettata subito in una cupa rabbia. Avrebbe voluto a tutti i costi potermi nutrire lei direttamente, attaccandomi al suo seno. Pazienza, mi sarei dovuta accontentare di un «latte speciale». I primi sei mesi sono stati un continuo rigurgito e un susseguirsi di pianti disperati: di notte non lasciavo mai dormire nessuno. Mia madre era molto ansiosa, mi pesava di continuo, temeva che potessi ammalarmi, che non crescessi; questa era la norma. Se non crescevo di peso, il pediatra veniva interpellato immediatamente. Pure la nonna materna che abitava vicino a noi era preoccupata, e spesso la subissava di consigli. Mia madre si sentiva del tutto inadeguata, e ancora oggi ricorda con senso di colpa il fatto di non avermi allattato al seno, di non essere stata in grado di nutrire la sua adorata figlia.
Per sua fortuna, e forse anche mia, dopo i sei mesi di assenza per maternità decise di tornare al lavoro e io venni affidata alle nutrienti cure della nonna. Da quel momento, tranne rari momenti in cui il mio corpo proprio non ne voleva sapere di crescere, l’ago della bilancia è sempre salito con velocità autonoma, con scatti a volte repentini, senza tenere in giusto conto la mia crescita in altezza. Sino ai 6 anni stavo quasi tutta la giornata con la nonna, donna energica che aveva cresciuto quattro figli. Accudiva, oltre a me, altri due nipoti, figli dello zio materno. Giocavamo sempre, tra noi e con la nonna. Il nonno stava poco in casa ma era sempre lui ad accompagnarci: all’asilo, dal medico e alla sera nelle rispettive case.
La casa dei nonni era vicina, meno di un chilometro, da quella dei miei genitori. La nonna era un’ottima cuoca, ma il nonno aveva il diabete e doveva stare attento agli zuccheri. La nonna sorvegliava che non mangiasse dolci e non bevesse vino. In una parte segreta della dispensa c’erano dei dolci ma erano per noi bambini, erano il premio se eravamo buoni.
Il peso già cominciava a preoccupare i miei genitori, ne parlavano con la nonna che non sentiva ragioni. Lei faceva da mangiare cose buone, sane e secondo lei un po’ di ciccia era solo il segno della salute. In realtà il mio peso saliva con regolarità. La nonna era orgogliosa di me: ero tranquilla, non facevo mai danni, ero ubbidiente e affidabile e dimostravo di apprezzare la bontà delle sue ricette. Quando la sera mio nonno mi riportava a casa dai miei genitori di solito avevo già cenato, ma mi mettevo di nuovo a tavola con loro e mangiavo. Erano stanchi ma felici, mi adoravano. Mangiavo di gusto e loro gioivano. Così riuscivo a fare felici tutti, nonni e genitori. D’altra parte avevo la chiara sensazione che darmi da mangiare fosse l’attività per loro più gratificante. Anche a loro piaceva mangiare. Eravamo una famiglia felice, almeno credo.
Certo, mia madre era sempre apprensiva, mi chiedeva se avevo riposato, fatto i compiti, se avevo fatto merenda e cosa avevo mangiato dalla nonna. Una volta ricordo che la mamma e la nonna bisticciarono e capii che era a causa mia. Mia madre rimproverava la nonna perché mi riempiva la pancia di un sacco di schifezze: dolcetti, merendine e pastine. Ero grassa e dovevano stare attenti al mio peso, non voleva che diventassi grassa come lei. Da allora smisi di raccontare a mia madre la verità su quello che mangiavo dalla nonna. La nonna lo aveva capito e mi faceva intendere che la nostra alleanza, il nostro segreto, era un segno del nostro affetto.
Quando avevo 7 anni arrivò mio fratellino, Marco. Mia madre decise allora di stare a casa dal lavoro.
Tutto procedeva bene. Spesso ero triste, non avevo più i miei cugini con cui giocare, mia madre aveva sempre paura di non sapere bene come allevare i figli. Per ogni minimo problema finivamo dal pediatra o addirittura da uno specialista. Mio padre si lamentava di questo continuo correre dal medico. La nonna rimproverava sempre mia madre: «Non sai fare questo e quello, non vedi che la bimba non sta bene, non ti accorgi che è vestita troppo, avrà mangiato abbastanza? Coprila di più!»
Anche la mamma aveva messo qualche altro chilo di troppo. Un giorno affermò decisa: «Ora che ci mettiamo a dieta, è giunto il momento di dimagrire». Avevo 8-9 anni. Iniziò una stagione di minestroni. Minestrone a pranzo e zuppa di verdura la sera. Era un gioco, all’inizio bello e divertente ma in seguito ci ritrovavamo a mangiare tristemente e a scherzare sulle linguine al pesto o gli spaghetti al ragù o la cotoletta alla milanese. La dieta per me era attenuata e valeva solo a casa, certo non quando si andava dai nonni o dagli zii. In assoluto non valeva per papà, che non ne voleva sapere, e neppure per i giorni di festa. In quelle occasioni ci concedevamo un piccolo dolcetto, così piccolo che a me e alla mamma dava solo sofferenza. Di nascosto dalla mamma qualche volta il papà mi allungava un boccone di qualcosa di buono. Dopo neppure tre mesi, una sera, venne decretata la fine della dieta. Mia madre aveva perso 5-6 kg, io forse 1-2. Non lo sapevamo con certezza perché c’erano sempre problemi con la bilancia. Si era stabilito di pesarsi una sola volta la settimana, la domenica mattina. Era come un rito, inizialmente scherzoso, divenne ben presto angosciante. Avevamo sempre una scappatoia quando il peso non era quello atteso; dicevamo: «Forse la bilancia non funziona, le pile saranno scariche, l’intestino non è stato regolare, avrò trattenuto più liquidi». Sono certa che mia madre si pesava di nascosto anche gli altri giorni. La pesata settimanale era un rito doloroso che decretava se quella domenica era tranquilla, se si poteva mangiare ciò che si voleva o se si doveva sì mangiare quello che si voleva ma un po’ di nascosto e con sensi di colpa.
Verso i 10 anni ci fu la fase dell’attività fisica. Mia madre era in palestra tutti i giorni, mio padre incoraggiava tutto questo. Lui era uno sportivo, voleva che mia madre riprendesse a sciare. Io venni iscritta a una società di pallavolo. All’inizio mi divertivo, era bello stare con altre ragazze, alcune della mia età e altre un po’ più grandi. Dopo i primi due mesi si doveva poter iniziare a giocare. Alle prime partite partecipai ma in seguito non venivo messa in squadra. Un giorno l’allenatore mi disse che forse avrei dovuto mettermi a dieta, che lui mi poteva dare dei buoni consigli. Qualche giorno dopo mia madre a tavola lo riferì a mio padre. Dovevo dimagrire, era un imperativo. Quella sera piansi da sola in camera mia. Sentivo il peso del giudizio dell’allenatore (e sono certa anche delle compagne) e il dispiacere e la delusione di mia madre. Per un po’ mamma provò a portarmi a correre ma lo sforzo era sicuramente sproporzionato ai risultati. Chilo più o chilo meno mi sembrava che nulla cambiasse e sentivo che mi mancava qualcosa per poter dimagrire. Meglio stare a studiare, lo studio mi dava grandi soddisfazioni. Lì ero io la campionessa. I miei compagni mi chiedevano sempre aiuto e le altre mamme erano felici se uno di loro veniva a studiare con me.
Ricordo bene quando, all’età di 11 anni, per l’ennesima volta, e non certo l’ultima, mia madre sentenziò: «Da domani ci mettiamo a dieta, ma una vera dieta». Aveva deciso di farmi fare la dieta sotto controllo medico dopo che il nostro pediatra, durante una normale visita di routine, aveva proclamato, con aria mista di preoccupazione e di rimprovero: «Questa bambina pesa troppo, è troppo grassa e dobbiamo fare qualcosa». Per me non era una novità, già altre volte le battute di qualche parente, di mio padre stesso, avevano sottolineato in modo molto pesante che avevo la pancia, le gambe erano troppo grosse, insomma: ero una cicciona.
Da almeno un paio d’anni mia zia, la sorella di mia madre, quando veniva a cena da noi la domenica rimproverava mia madre perché diceva che non stava attenta alla mia alimentazione. Il ritornello era sempre quello: «Troppo grassa, dovete fare qualcosa per farla dimagrire». Mia madre soffriva di questo, si capiva che si sentiva accusata e si lamentava con mio padre e indirettamente con me. Che colpa aveva lei se io continuavo a chiedere da mangiare, d’altra parte mangiavo così di gusto che non se la sentiva di limitarmi. Farmi dimagrire era impossibile, a loro dire io mancavo completamente di forza di volontà; se la nonna e la zia avessero provato a farmi dimagrire – diceva mia madre – se ne sarebbero rese conto in prima persona. Quante volte provando a fare la dieta, cioè tentando di dire no a quello che più mi piaceva (pane, pasta e dolci in ordine sparso), già il primo giorno mi ero messa a piangere, volevo ancora un po’ di pasta o degli altri biscotti. Anche mia madre pesava troppo, aveva una lunga e frustrante esperienza di lotta contro la ciccia. Lei almeno aveva delle giustificazioni: era ingrassata con le gravidanze, in particolare la mia, la prima, le aveva fatto guadagnare non meno di 15 kg. Mio fratellino, di sette anni più piccolo, lui sì che era magro e scatenato. Eppure eravamo figli degli stessi genitori, non si capacitava di questa differenza. La figlia più grande bella paffuta, per non dire grassa, buona e pigra, studiosa e responsabile; il figlio maschio più piccolo, scatenato, iperattivo e magro. Mia madre lodava sempre le mie buone qualità e le contrapponeva all’iperattività, svogliatezza e menefreghismo di Marco. In verità non si capiva bene per chi facesse il tifo perché almeno Marco era una «simpatica canaglia, magro» mentre io ero una «brava bambina che non dà nessun problema ma grassa». Ero infelice ma non potevo e non riuscivo a farlo vedere, mi facevo andare bene tutto, per non tradire la fiducia degli altri dovevo essere brava.
La grande sofferenza per il corpo si manifestava in due aspetti. Il primo erano le prese in giro dei compagni che non mi risparmiavano mai. «Cicciona, ciccia bomba, grassona» erano gli epiteti più frequenti e neppure i più volgari. Sorridevo, non ascoltavo, cercavo di rispondere con parolacce e offese a questi attacchi, ma era difficile far fronte non a uno ma a venti compagni per i quali mi sentivo come la rappresentazione di tutto ciò che di più disgustoso ci può essere. Avevo qualche amica, ma quelle due o tre amiche erano comunque ragazze ai margini, le più sfigate, studiose e un po’ imbranate. Le ragazze «speciali», che contavano, quelle la cui compagnia veniva ricercata, avevano per me solo brutti commenti. Mi evitavano allo stesso modo con cui avrebbero evitato un paio di jeans fuori moda, assolutamente sbagliati.
Il secondo aspetto difficile della mia condizione era rappresentato dal momento in cui mia madre decretava che bisognava andare a fare compere, trovare dei vestiti per me. Anche in questo caso la sofferenza era forte, dovevo fare sempre finta di niente. Giravamo molti negozi, ma mia madre non trovava mai nulla che mi stesse bene, vestiti adatti a me sembravano non ne esistessero. Non trovavo nulla di pronto, tutto si doveva allargare, adattare, sistemare. Mia madre era veramente sconfortata e sentivo sempre un suo profondo senso di vergogna e colpa per la mia condizione. Le commesse, poi, sottolineavano perfidamente le mie forme, con un’aria mista di comprensione e insofferenza ribadivano la necessità di entrare almeno in una 46. Mi guardavano come un fenomeno strano. In fin dei conti non bastava forse darmi un po’ meno da mangiare! Eppoi, suvvia cosa ci voleva per farmi capire che così non poteva andare. Cosa c’era nel mio cervello che non funzionava, non avevamo forse uno specchio in casa?
Certamente avevo molta «visibilità», ma nessuna possibilità di essere accettata, di poter stare «alla pari» con i miei coetanei. Avevo ben capito che certe cose, certe situazioni, non erano per me, ma era solo una sensazione confusa. In fin dei conti ero ancora una ragazzina.
Verso i 13 anni la mia condizione mi divenne più chiara, soltanto allora potei capire che forse avrei dovuto accontentarmi di una vita ai margini. Qualsiasi attività fisica mi vedeva emarginata e penalizzata. Se cercavo di partecipare in qualche modo, il risultato migliore era di sudare come nessun altro, di avere un fiatone impressionante e di arrivare sempre ultima. Nessuno, in un gioco di squadra, mi voleva con sé. Per quale motivo avrei dovuto sottopormi a una tale tortura? Meglio, molto meglio, glissare, rinunciare, dire che non ero interessata e dedicare il mio tempo ad altro. In questo modo il mio isolamento divenne sempre più grande rispetto ai compagni «normali». Rari gli inviti per una festicciola, a me sembravano «rubati», ottenuti per indulgenza verso la mia condizione. Mi restava qualche imbranata come me, una cugina (forse costretta dai parenti) e la compagnia della parrocchia.
Avevo altri campi in cui eccellere: lo studio e la musica. Leggevo tanto, sembrava un’attività in perfetta sintonia con il mio personaggio. Anche nelle conversazioni con gli adulti ero molto apprezzata. Per la musica mi impegnavo moltissimo. Ero entusiasta, mi piaceva veramente sentire quei meravigliosi suoni uscire dal pianoforte e sapere che ero io che stavo producendo quella melodia. Se dentro di me pensavo di potermene fregare del mio peso, del mio corpo orribile, soffrivo però per mia madre che stava male per me e per i rimproveri diretti e indiretti che riceveva. Ma che cavolo di colpa aveva lei. Ero io che mi ingozzavo, che non sapevo fermarmi e continuavo a mangiare. D’altra parte non capivo come avrei potuto fermarmi dato che avevo sempre fame. Più mangiavo e più avevo fame. In certi momenti mi assaliva uno strano stato d’animo che non avrei potuto spiegare a nessuno, sentivo come un vuoto incolmabile dentro di me, una sensazione di noia assoluta, una completa mancanza di ogni suono. Ecco, in quei momenti solamente un bel pacco di biscotti poteva riportarmi a una realtà senza sofferenza, una sorta di anestesia saporita. Voglio precisare: non esisteva una realtà senza sofferenza; rifiutata e con sensi di colpa cercavo di sopravvivere relegandomi per scelta (?) a una vita che sapevo nessuno riteneva del minimo valore. Almeno così a me sembrava.
Aiutavo mia madre in casa nei lavori di tutti i giorni, lo facevo volentieri, mi sentivo più buona e mi sembrava così di pagare una sorta di penitenza. Anche da questo derivavano elogi e complimenti con la coda di invidia di parenti e amici dei miei. Tutto finto ai miei occhi. In fin dei conti non ero forse io la colpevole di tanta sofferenza dei miei genitori? Aiutarli era il minimo che potessi fare. Aiutavo in casa più che potevo, così non avevo neppure il bisogno di trovare altre attività. Anzi, avevo un’altra attività che consisteva nell’aiutare mia madre a contenere lo scatenato fratellino che arrivava a volte a sfinire tutti. Mi chiedevano aiuto e io mi prestavo.
Verso i 14 anni, in casa si era discusso se trovare una baby-sitter per il mio fratellino; mia madre aveva deciso, d’accordo con mio padre, di ritornare al lavoro. Avevo capito che c’erano dei problemi che riguardavano i soldi. Mia madre riprendeva il lavoro per guadagnare qualcosa e la baby-sitter costava troppo. I soldi era meglio risparmiarli ma mia madre avrebbe avuto troppo poco tempo per andare a riprenderlo alla fine della scuola. Ricordo la mia immediata decisione: «Posso badare io a Marco, posso andare a prenderlo all’uscita di scuola e il pomeriggio lo tengo con me». Non serviva più una baby-sitter, c’ero io. Tutti erano contenti perché così erano anche più sicuri che avrebbe fatto i compiti per bene.
Certo, i miei impegni erano tanti ma mi sembrava giusto così, e poi ne avevo grandi vantaggi. Non dovevo più trovare scuse per non andare dalle amiche, facevo quello che più piaceva, i miei genitori erano contenti. Mi sembrava di essere diventata più grande. Ovvio il grasso restava e cresceva. Crescendo, il grasso mi opprimeva e mi proteggeva.
Ogni tanto si riparlava della dieta ma solo di sfuggita. Sembrava un argomento tabù. Mia madre avrebbe voluto dimagrire, ma aspettava il momento buono, ora aveva troppi impegni. Io avrei dovuto farla perché ero piccola e per me sarebbe stato facile. C’era una soluzione magica, una parola che poteva risolvere il tutto: «Basta un po’ di buona volontà». Io ci pensavo spesso, e non nego che qualche volta ho pensato di provarci, ma era una scelta difficile con più rischi che vantaggi. Se riuscivo, non avrei comunque fatto nulla di eroico, avrei semplicemente applicato quella buona volontà che «dovevo» avere; se non ci riuscivo era l’ennesima prova del mio essere un’incapace, priva di ogni minima volontà e determinazione.
Intanto ero arrivata alle superiori, al liceo. Studiavo tanto, andavo a scuola di piano, aiutavo in casa e badavo a quello squinternato di mio fratello. Non bastava tutto questo per dare prova della mia volontà: io dovevo dimagrire. Ma possibile che nessuno capisse quanto ero stanca e stressata! Come avrei potuto rinunciare a ciò che più mi gratificava, al piacere che in minima parte riuscivo a ricavare? Forse dovevo soltanto soffrire. Per questi motivi non potevo rischiare di dire ai miei che mi mettevo a dieta. Doveva essere una decisione segreta; certo, loro sarebbero stati contenti di sentirmi dire «domani mi metto a dieta», ma non potevo farlo. Da quel giorno avrebbero scrutato ogni mio gesto, ogni boccone, per capire se c’era qualche etto in meno. Quando poi non avessero visto neppure un minimo accenno a un calo di peso, mi avrebbero interrogata mostrando tutta la loro delusione. Allora era meglio provarci in silenzio, giocarsi da sola questa chance. Per una settimana riuscivo a mangiare meno almeno davanti ai loro occhi, ma il pomeriggio, quando mi trovavo sola con mio fratello, il pensiero di ciò che c’era in dispensa mi angustiava, mi tormentava dentro e alla fine cedevo. Avrei riprovato un’altra volta, magari il giorno dopo. Piano piano avevo sviluppato il pensiero magico che un giorno o l’altro sarei riuscita a mangiare meno e a non avere più interesse per il cibo. Ecco la vera soluzione: «non avere più interesse per il cibo». Non bastava la dieta, cosa peraltro impossibile, dovevo semplicemente non avere più alcun interesse per il cibo. Dovevo imparare a digiunare. Dovevo solo convincermi che gli spaghetti al ragù, la cotoletta, il prosciutto, i frollini, le brioches, le pastine, la cioccolata e qualche altra decina di cose buone non mi sarebbero più piaciuti e, anche affamata, avrei saputo rinunciare in cambio di un bel piatto di insalata. Sarei finalmente diventata un’altra persona. Magra, amata, ricercata, con mia madre orgogliosa di me. La triste realtà era invece che le cose peggioravano anche a casa, dove sino a un anno prima stavo bene.
A tutto questo si era aggiunto un dolore ulteriore. A scuola le mie compagne erano tutte più magre di me. Tutte però parlavano di dieta e della voglia, o meglio necessità, di dimagrire. Solo così aveva un senso mettere le maglie, i jeans e gli altri vestiti alla moda. Quante lacrime ho versato durante quel primo anno delle superiori, quanto dolore tenuto segretamente dentro di me. Unica consolazione era pensare ai soldi che facevo risparmiare ai miei.
Mio fratello era sempre più ribelle, scanzonato, allegro e menefreghista. Cercavo di farlo studiare ma non ci riuscivo. Lui poi mi prendeva in giro, pesantemente. Quando ho provato a spiegare a mia madre come mi trattava mio fratello ho ricevuto una dose ulteriore di rimproveri. Io ero la più grande e i miei si aspettavano che aiutassi di più, che facessi fare i compiti al più piccolo. Ero diventata un fallimento su tutti i fronti, almeno questo era il mio stato d’animo.
A 15 anni finalmente si andò dal dietologo, un dietologo vero e famoso. La sentenza fu pesante. È affetta da una obesità grave. Peso 112 kg per 162 cm. Eravamo agli sgoccioli, se non dimagrivo chissà quali acciacchi mi sarebbero piombati addosso. Forse era già tardi. Dovevano pensarci prima. Un fallimento completo, ma ora almeno c’era una speranza. Mi sono sottoposta ad alcuni esami del sangue con la speranza di avere una malattia, qualche ormone che andava per conto suo (questo ci avrebbe reso tutti innocenti). Ma mai una volta che mi sia andata dritta: gli esami erano perfetti, ero io l’unica imperfetta (in compagnia di mia madre che al medico aveva pur detto: «Dottore mi creda ho provato in tutti i modi ma non c’è mai stato nulla da fare, mangiare sembrava fosse l’unico suo interesse! Se le toglievo i biscotti mi faceva delle storie incredibili»).
Dopo una decina di giorni, fatti gli esami e accertamenti vari, mia madre tornò a casa con la dieta scritta e specificata nei particolari. Decisi di metterci tutto il mio impegno. Avanti a testa bassa. Mai più biscotti, merendine, panini al pomeriggio, gelati à gogo. Niente di tutte quelle schifezze che «fanno ingrassare». Iniziò il rito della pesata dal medico. Mia madre mi aveva coinvolta in una passeggiata pomeridiana con lei («Così ci aiutiamo a dimagrire perché, sai, anche a mamma serve perdere un po’ di chili»). Le rinunce erano tante, niente gelato, l’obbligo di una colazione equilibrata (che nessuno faceva a casa mia), una passeggiata tutti i santi giorni, nessun dolcetto. Al compleanno di mio fratello mi hanno dato una mignon: «Se la merita, è così brava». Mia madre era stanca della passeggiata, aveva così tanto da lavorare in ufficio e a casa. Io avevo mille impegni e trovare il tempo per tutto, passeggiata compresa, sembrava ogni giorno più difficile. Per non dire poi che la pelle delle cosce si era tutta arrossata. Il gioco (o meglio, la fatica) valeva però la candela. Dopo due mesi ero dimagrita di 6 kg. Erano tutti contenti ma io avevo capito che, continuando ci sarebbero voluti almeno due anni per poter raggiungere i 60 kg, peso ritenuto dal medico e da tutti come un buon obiettivo. Provai a mangiare ancora meno, ma la pancia e la testa mi mandavano dei segnali inequivocabili: fame, voglia, appetito, malessere, nervosismo, ronzii e altro ancora. Il pensiero correva sempre al cibo buono, che magari non era in casa mia ma sicuramente al negozio di generi alimentari. Quando guardavo un film mi colpivano le scene dei pranzi, le scene con il cibo come primo attore erano le più interessanti. Sfogliando le riviste, mi soffermavo sulla pubblicità di qualche leccornia, consultavo libri di ricette, mi fermavo al supermarket a guardare tutto quel ben di dio che mi era stato proibito negli ultimi tre mesi. Almeno però avevo buona volontà. La mia buona volontà era molto aiutata dai sensi di colpa. Cosa avrebbero pensato i miei genitori, cosa avrebbe detto la nonna e la zia se anche questa volta avessi fallito? Al controllo dal medico, dopo il quarto mese, il risultato era favoloso: dimagrita di 8 kg, massa magra aumentata di 2 kg, come fossi dimagrita 10 kg. Una gioia grande, bisognava continuare. In verità quando mi guardavo allo specchio non vedevo la differenza, anzi mi sentivo ancora più grassa, sembrava quasi che allo specchio e nel provare i vestiti il mio corpo si dilatasse. Al sesto mese altri due chili in meno, bene ma con una punta di delusione. Io e mia madre ci aspettavamo almeno il doppio, tanto erano stati duri gli sforzi fatti.
Improvvisamente avvenne la catastrofe. Dopo un altro mese, durante il quale mi sembrava di avere fatto tutto per bene, la bilancia aveva sentenziato: peso stabile, nessun calo. Interrogativi a più non posso. Mia madre giurava che aveva fatto tutto come concordato. Il medico, era chiaro, aveva individuato il responsabile e lo indicò con alcune semplici domande: «Hai forse mangiato qualche cosa a scuola, magari hai piluccato qualcosa il pomeriggio a casa, ti comperi dei dolcetti? Quante ore passi davanti alla tv? Perché non ci dici la verità?» domande che erano dei veri e propri colpi bassi. Mi sono sentita sfiduciata da mia madre e dal medico, dentro mi sentivo come un martire il cui martirio non era stato visto e apprezzato da nessuno. Ero presa tra due sentimenti opposti: gliela faccio vedere io a quello stronzo di medico che non mi crede! E, all’opposto, che vadano tutti al diavolo, ora mi mangio quattro pacchetti di Kit Kat.
A casa, discussione anche con mio padre, deluso, sul cosa fare e come rimediare. Come se non bastasse il medico costava caro. Il pomeriggio seguente, dopo una lite con mio fratello, mi sono finalmente liberata e mi sono mangiata un pacco di schiacciatine al basilico. Voracemente, velocemente, anesteticamente. Erano dolorosamente buone. Subito dopo mi ero sentita pervasa da un misto di gratificazione, benessere, senso di colpa, dolore. Mi erano sempre piaciute le schiacciatine… ecco! erano riusciti a farmele detestare! E pensare che erano anche il cibo preferito dalla mamma. Come rimediare? Non vedevo soluzioni. Forse avrei potuto vomitare come avevo sentito che facevano alcune mie compagne, ma non avevo la forza necessaria. Promessa: non ci casco mai più. Ma ormai era una marea montante. Il giorno dopo a scuola mi sono fatta a merenda un panino con il salame. Avevo una nuova soluzione. Non dire nulla a nessuno e nascondere il mal fatto. Dal medico, dissi a mia madre, non volevo più andare: costava un sacco di soldi e non ci aiutava un granché. Non mi volevo neppure più pesare. Che stessero tranquilli, ci pensavo io al mio grasso. Mi madre acconsentì. In fin dei conti anche lei aveva avuto i suoi rimproveri. Era una alleanza non esplicita che andava bene a tutti. Meglio chiudere quella esperienza.
Per un po’ non si parlò più di dieta e del mio peso. A qualche timida domanda la mia risposta era risolutiva: «Va tutto bene». Il mio peso intanto cresceva. Qualche volta i miei timidamente mi dicevano: «Quanto pesi? Mi sembri aumentata». Io negavo: «Ma no, sembra, sono sempre uguale». Era una pietosa bugia. La loro attenzione nei riguardi della mia dieta mi angosciava e mi umiliava terribilmente.
Avevo sperimentato una cosa che poi ho scoperto accade a tutti. Fare la dieta riesce all’inizio, per qualche mese è possibile calare di peso. In seguito il calo però è sempre più difficile, se proprio ti impegni resti a peso stabile, ma poi c’è la recidiva. Sì, recidiva nel senso che non si riesce più a rinunciare alle cose buone; lo stile di vita, inteso come attività fisica globale, non si modifica per una passeggiatina ogni tanto. Tutto resta come prima con la differenza che non fai altro che pensare a tutto il cibo buono a cui hai rinunciato; alla fine pareggerai i conti recuperando tutto quel buon cibo a cui hai rinunciato. Hai perso 4 kg e dopo alcuni mesi te ne ritrovi 6 in più!
A 15-16 anni le prese in giro sono meno frequenti, non sono così cattive e perfide come alle medie. I compagni non dicono nulla, qualche ragazza ti è amica per la scuola, ma non per altro. Per ogni ulteriore aspetto della vita sociale di un adolescente vieni trattato come un paria. La tua vita sociale è ridotta al minimo e non fai nulla per cambiare, anzi quell’isolamento ti protegge. Chi ce l’avrebbe mai il coraggio di presentarsi a una festa dove comunque non conoscerei nessuno? Con chi dovrei parlare? Dovrei stare in un angolo mimetizzandomi con la tappezzeria? È buffo che una persona con un corpo ingombrante come il mio debba passare la vita a nascondersi, a cercare di diventare invisibile, perché è chiaramente una lotta persa in partenza. Sono troppo grassa per nascondermi, sono «troppa» per sparire. E pensare che sarebbe il mio più grande desiderio. Per capire chi e come sei devi solo osservare come ti guardano tutti. Certo, vorresti anche tu un amico, un ragazzo, avere una storia. Ma come si fa? Meglio lasciar perdere e non farsi illusioni.
I sensi di colpa divengono giganteschi, le ansie, le paure, il sentirsi una persona sbagliata ti hanno ormai minata nell’intimo. Non hai nessuna stima di te, ogni sguardo degli altri penetra nel tuo corpo e diventa un giudizio inesorabile: «Fai schifo», «Vergognati!» Eppure, mi dico, sono brava a scuola, non creo problemi… possibile che tutti non facciano che accorgersi sempre e soltanto del mio peso? Uno scrittore ha detto che lo sguardo degli altri è lo specchio migliore, il più preciso e insieme il più crudele. Non so se sia vero, ma so che a volte io leggo esattamente quello che si nasconde nello sguardo di alcune persone quando mi vedono: pena. Speranza di non essere mai come me o che non gli tocchino in sorte figli come me. Scherno e schifo, questi sono i sentimenti inconfessati di molti per quelle come me. Penso che molta gente potrebbe riservare persino a un criminale occhiate più clementi.
Anche uno sconosciuto in autobus mi ha detto: «perché non provi con… guarda che funziona», come se una persona come me che pesa 100 kg avesse bisogno di una informazione. Ah sì, hai ragione, mi era sfuggita, grazie per avermi detto come si fa a dare una sistematina alla mia vita da grassona sfigata. Mancavi solo tu per illuminarmi!
Ho una corazza, ho sviluppato un sistema difensivo potente. Ignoro il mio problema, cerco di non guardare mai gli altri, penso solo al mio lavoro. Eseguo quello che devo, sorrido sempre, mi va bene tutto. Non posso permettermi critiche, non posso aprire un varco alle osservazioni degli altri, potrebbero giungermi ferite gravi che non so se riuscirei a tollerare. Ho imparato a mascherare le mie emozioni, non provo nulla. Ho imparato a vestirmi al mattino senza mai guardarmi allo specchio.
Il cibo rimane per me la migliore anestesia. È il migliore amico che non ho, è il fidanzato che forse non troverò mai. Il cibo mi salva dopo avermi messa in trappola. Il cibo è il mio nemico e insieme l’unico compagno affettuoso che io abbia avuto.
La mia vita alimentare ha una sua regolarità. Quando sono sola vengo presa a volte, non sempre, da momenti di ansia. Sento un vuoto interiore, solitudine, tristezza a cui rispondo efficacemente con due pizzette e un succo. Altre volte il rimedio è più dolce e più distruttivo: non dà spazio a scusanti. Mi ingoio anche sei-otto pastine. Squisite e velenose, tanto è forte poi il mal di stomaco e la nausea. Quando poi si va dai nonni si mangia, la nonna insiste, c’è la zia che mi rimprovera, rimprovera tutti; la nonna mi difende e dice che mangiare con gusto non ha mai fatto male a nessuno. Quando invece vengono degli amici a casa mia c’è ogni ben di dio. Come resistere? Impossibile! La presenza di amici di famiglia impedisce ogni rimprovero e allora mangio tutto quello che voglio. Mi restano solo le giornate in cui siamo a casa io e la mia famiglia, a pasto riesco anche a dare l’idea di una alimentazione quasi normale.
Ultimamente mia madre è diventata cattiva, non mi capisce, si arrabbia se non mangio o se non faccio quello che lei ha deciso. Grassa sì, ma ubbidiente, servizievole. Così credo che mia madre mi voglia, niente di più. Il suo amore per Marco invece aumenta, anche se lui continua a combinare guai e a non impegnarsi nello studio. In compenso sta diventando un piccolo campione di nuoto, sembra che l’anno prossimo possa entrare a far parte della squadra a livello agonistico. Una volta ho sentito mia madre parlare al telefono con mia zia e dirle che avrebbe voluto dei figli con il mio carattere accomodante e la mia attitudine per gli studi e con la struttura fisica di Marco. Ormai sono abituata a questo genere di osservazioni, e la verità è che anch’io a volte invidio profondamente mio fratello, e ciò non fa che causarmi ulteriori sensi di colpa. Mi sento cattiva, oltre che brutta e grassa.
Mio padre è più tranquillo, ma mi sa che qualcosa è cambiato in casa. Forse è cambiato lui, credo sia stanco e in crisi con mamma. Non credo che tra loro ci sia più quel sentimento che li ha fatti sposare. A volte mi capita di pensare che sia tutta e solo colpa mia. Avrei voluto essere una persona agile e spensierata come mio fratello. Invece la mia pesantezza non è solo un referto medico legato all’obesità, è proprio la mia natura più vera. È la mia natura e insieme il mio destino: essere pesante, essere un peso, è questo il ritornello che descrive tutta la mia vita. Mi sento un peso per i miei, per me stessa. Ora ricordo quasi con rimpianto il tempo delle diete, non certo perché fosse un periodo sereno, o perché abbia mai portato cambiamenti effettivi. Lo rimpiango perché mi teneva vicina a mia madre. Era il nostro progetto, la nostra comune lotta verso un nemico insidioso. La nostra fame ci ha unite, la nostra crociata contro la pesantezza dei nostri corpi ha fatto di noi due alleate. Ma ora capisco con immenso dolore che la nostra fame ci ha divise, che il tempo delle diete è stato un tempo illusorio e pericoloso, che non ha fatto altro che rendere più difficili le cose, come se nutrirsi di illusioni e menzogne potesse davvero salvarci. Correre con mia madre al parco, conteggiare con minuzia le calorie dei cibi insieme a lei è un ricordo dolce ma, nello stesso tempo, inquietante. Ora ho capito che se siamo divise è perché siamo due perdenti, siamo entrambe sconfitte da una lotta che mi fa pensare con tenerezza e disperazione al personaggio letterario che in assoluto amo di più, alla sua lotta contro i mulini a vento. I libri mi hanno salvata, ma non perché la cultura sia la medicina a tutti i mali; la storia, la vita ci insegna tutti i giorni che non è così. Se mi hanno salvata è banalmente perché mi hanno permesso di vivere altre vite. Di correre, di amare, di trasformarmi. Il tempo delle diete mi ha fatto capire che il mio corpo non sarebbe mai cambiato. Mai. Nel corso degli anni mi sono stati proposti metodi di dimagrimento alternativi, interventi chirurgici, terapie di gruppo. La tentazione di accettare, di credere all’efficacia di tali metodi, è stata talvolta fortissima. Se non ho mai accettato è stato per la paura di fare di nuovo l’esperienza della presa di coscienza che, magari non subito, magari dopo un po’, il grasso sarebbe tornato, il peso sarebbe aumentato ancora. Non voglio permettere che questo accada, non voglio. Voglio risparmiare a me stessa questa ennesima umiliazione. Gli sguardi della gente per strada sono una prova più che sufficiente da superare ogni giorno, ogni minuto. L’imbarazzante fatica che ho nel muovermi, anche. E pensare che io mi sento l’animo di una gazzella, di un colibrì, di una farfalla! Ho un’anima leggera. Ciò che è pesante è tutto il resto: il corpo, il mio percorso, la mia lotta fallita, insomma, la mia storia. Una storia obesa. Quando mi guardo allo specchio non vedo la dismisura del mio corpo. O meglio, la vedo, ma quello che io vedo veramente è soprattutto il mio viso esausto. Sono stanca. È troppo faticoso. È troppo crudele. È inutile. Ora ho incontrato un medico, dicono sia molto bravo, mi ha fatto una buona impressione. Ho chiesto aiuto, che mi aiuti a stare meglio, semplicemente meglio con il mio corpo. I miei sono più tranquilli e forse un po’ più rassegnati. Io sono più lucida e più disillusa, tanti mi dicono che sembro molto più grande della mia età perché sono molto matura. Credo sia così, sono stanca perché ho dovuto crescere più in fretta.
Vado avanti, perché questa vita è la mia, questa è la mia storia, il mio corpo, e anche se a volte mi sembra che diventi ogni giorno più difficile io ci provo, ad andare avanti, imparo a vivere nella dismisura di un corpo pesante, muovendomi con lentezza tra le cose della vita e tra gli sguardi degli altri.
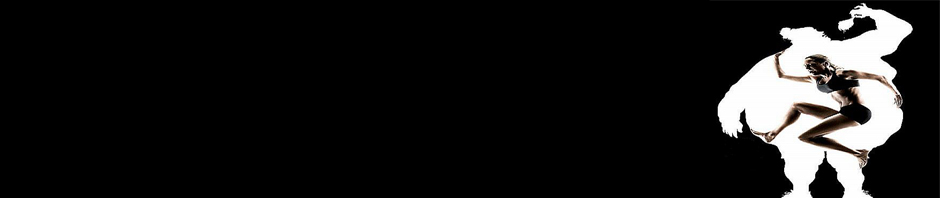

Leggerti è stato come rivivere i momenti più dolorosi della mia vita.
Quel sentire un \”Perchè non provi a metterti a dieta?\” ogni volta , la paura di mettersi a dieta per non dover poi fare i conti con qualcuno che ti guarda quando mangi per vedere se rispetti i consigli dati…La dieta fatta con la mamma (dieta che però ,mia mamma, è riuscita a seguire fino alla fine), lo shopping devastante prima delle grandi occasioni e poi le prese in giro , il prendersi in giro per rendersi più simpatica , almeno quello.
Ad un certo punto ho addirittura pensato di averlo scritto io questo post tanto è reale e sentito.
Vorrei esserti vicina, non per \”compagnia tra grasse\”, ma per affinità di pensiero e forse un po' di sostegno…
Ti abbraccio.
Linda